TESTIMONIANZE
L’arte di Victor de Sabatadi Giorgio StrehlerTratto da: Teodoro Celli, “L’arte di Victor de Sabata”, ERI/Edizioni RAI, Torino, 1978
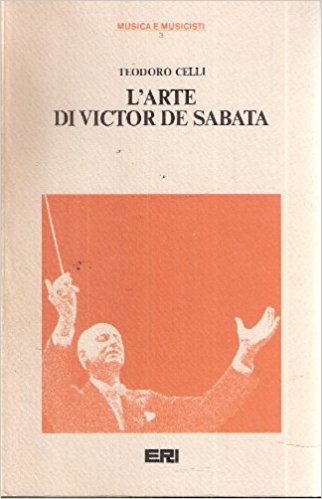
Per giudicare la superficialità e la mancanza di un minimo sentimento storico di tanta parte della critica e della musicologia italiana contemporanea> basterebbe il silenzio steso su Victor de Sabata, direttore d’orchestra, ma prima ancora, uomo di musica. Uomo di musica e non solo « mostro sacro » con quel tanto (o molto) dí demoniaco che il grande interprete porta sempre con sé.
O invece è toccato a de Sabata, l’ineluttabile destino che tocca a tutti noi interpreti di note o di parole; quello di sparire « dentro » la musica o la poesia del teatro, appena il nostro gesto non è più lì per farsi suono o. immagine. Certo è una lezione di umiltà che gli interpreti devono portare nel cuore sempre, anche quando pare che siano più folgoranti, soprattutto quando pare che essi possano essere eterni, tanto si identificano con l’opera che rivivono e fanno rivivere in misure diverse.
Victor, grandissimo trafitto dal raggio di sole della musica, è sparito un certo giorno che io ho sempre considerato terribile, in un silenzio pieno di incredibile pudore, in un « pianissimo smorzando », tenuto appena sulla punta delle dita come lui sapeva fare e nessuno, direi, come lui. L’ho ritrovato qualche volta — molto meno di quello che avrei dovuto — in una stanza alta sul mare, una stanza anonima e povera, con un pianoforte verticale aperto, mucchi di giornali letti e lui che studiava Ravel, a quel piano. Non dirigeva più da anni. Ma la musica era ancora con lui. Ne era ancora l’esecutore attento e fulminante nelle intuizioni e adesso sacralmente dimesso come mai. Come mai l’ho amato e rispettato e capito. Non poteva dirigere più, col suo cuore come « doveva » per gli altri. Suonava allora per sé e per la musica, in un minimo di esistenza. Questo il destino che si era scelto.
Victor de Sabata o del demoniaco, dicevano. Io direi o della grazia, della più incredibile grazia del suono ed insieme a questa, della lacerazione del suono, della dolcezza più sinuosa e della violenza ritmica più implacabile.
Cioè de Sabata o della completezza di una natura tutta musicale fino all’ultimo atomo e quindi capace di avvicinarsi ai mondi più diversi e lontani. Il pubblico e molta parte degli addetti ai lavori vedevano in lui il demiurgo, l’affascinatore, ammiravano spesso soltanto, perché più facile, più comodo, la superficie smagliante. Non riuscivano sempre a toccare la sua realtà di grande interprete «universalizzante» per nulla simile al direttore d’orchestra che piega la musica a sé o a quello che, per mancanza di mezzi interiori, sembra piegarsi lui alla musica, mentre si tratta soltanto di debolezza della personalità.
Penso, in questo momento, ad una esperienza che io ho avuto con Victor, fratello maggiore, più anziano e celebre, al quale mi avvicinavo allora con tenerezza e timore e soprattutto con grande rispetto. Tutte cose che oggi mancano a tanti o a troppi che nulla devono mai a nessuno e che credono di dissacrare il mondo, con il gelo del loro cuore di eterni adulti.
Era il Pelléas et Mélisande di Debussy che Victor diresse un certo anno, in un certo momento alla Scala con una edizione francese, con scene antiche francesi e costumi francesi. Cose antiche e senza senso quasi. Alcuni cantanti straordinari, però. Alle mie prime regie liriche allora, Victor mi chiese di « dargli una mano » a metter su questo «Pelléas» già messo su mille volte altrove. Veramente non c’era quasi niente da fare; tutto già troppo predisposto, ripetuto troppo.
Pure per stargli vicino tentai l’impossibile che fu proprio impossibile: rifare uno spettacolo vecchio con il materiale vecchio come se fosse nuovo. Sapeva anche lui, in fondo, che la partita era perduta sul mio piano. De Sabata a differenza di molti direttori d’orchestra conosceva molto teatro e non solo quello di musica, aveva uno straordinario interesse per lo spettacolo ed i suoi problemi. Se li eludeva o li cancellava era perché non poteva, allora, fare altrimenti. In quel momento storico per il teatro in musica là dove noi cominciavamo a lavorare, c’era pochissimo da fare.
Victor mi diceva spesso nel nostro dialetto (tra molte altre cose, ci legava una radice triestina comune e l’amore per le barche a vela) « io là, chiudo quasi sempre gli.. occhi e guardo giù nell’orchestra. Ma il pubblico? ». Doveva insomma farsi cieco musicante, molto spesso, per amore della musica.
Così fu quel « Pelléas », nonostante il mio oscuro lavoro. Ma «con gli occhi chiusi» quello che succedeva in quel teatro non è dimenticabile. Il flusso musicale che nasceva da un’orchestra così rarefatta che pareva suonasse quasi d’aria e d’acqua. Il trascolorare del suono e delle armonie di Debussy con una iridescenza dí perla e dí fiamma. Le voci lievi e gravi — ricordo ancora benissimo quel Golaud che egli aveva reso ancora più bruno e morbidamente tragico — che si univano e si scomponevano con piccole sospensioni improvvise, tutte nella musica e tutte sue, respiri del cuore e battiti dell’anima.
E ricordai questo, proprio nei mesi in cui stavo studiando, a fatica, il Macbeth di Verdi. Scelsi, ineluttabilmente, la sua edizione rubata ad una recita non molto felice, con mezzi abbastanza precari. C’era là un incontro straordinario con la Callas. Ma c’era, prima di tutto, la chiarezza lancinante della presa di contatto con Verdi di de Sabata. La nettezza del gesto invisibile, la scelta esatta della perentorietà verdiana che non è mai sbrigativa ma essenziale. C’era, ecco, sì, il demonico, prima di Verdi e prima di Verdi di Shakespeare e poi di de Sabata, che serpeggiava di continuo come un bagliore nella tenebra ed esplodeva in certi momenti come fiamma di salnitro su piombo fuso. Di contro, ritornava dentro quel « Pelléas » a stabilire la misura di un vero, grande interprete. In questa larghissima misura stava per me de Sabata e nella sua latitudine umana. Stranamente infantile, a tratti, e in altri momenti allontanata quasi dalle cose del mondo. Mai gelida. Mai distaccata. Mai di maniera. E soprattutto generosa, con molta semplicità.
Resta poco, troppo poco, della musica che egli ha fatto suonare per noi, per il mondo. Non era ancora l’epoca dei grandi divi delle musicassette, non era ancora il momento del giradischi stereofonico e delle nove sinfonie in TV con violoncelli ín dissolvenza sulle trombe, e mani in dissolvenza su visi che soffrono tanto. E Victor non fu un commerciante di se stesso e, attraverso se stesso, della musica che era in lui. Proprio oggi a me sembra che anche questo conti: ristabilire fin quanto è possibile un profilo dell’arte più severo e più schivo. Una lezione che conta pochi maestri, un filo che passa da Walter a Klemperer, secondo me, e a pochissimi altri, e di cui il caro, caro Victor è un punto inequivocabile.
Maestro di musica perduto, in molta musica mistificata dopo, Victor de Sabata al quale un libro, sempre molto tardivo, non può restituire quello che gli altri, al suo momento, pur tra applausi e pezzi di carta stampati, non hanno saputo dargli.
