TESTIMONIANZE
TESTIMONIANZEImmagine di Victor de Sabatadi Alfredo MandelliTratto da: “Victor de Sabata – Nel centenario dalla nascita”, Teatro alla Scala, 1992
Ringraziamo il Teatro alla Scala per l’autorizzazione a riprodurre questo testo.
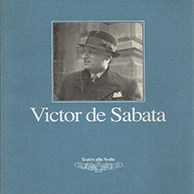
Una fotografia di gruppo, ripresa nel giardino di un palazzo. Dieci ragazzi e quattro ragazze, in tenute dal gusto ancora ottocentesco, che vorrebbe esser di gala. Al centro, tra le fanciulle, un ragazzo dal volto ovale, con un rotolo di musica in mano. Forse il rotolo è il discendente di quelli che, secoli prima, servivano ai maestri di cappella per scandire la battuta; un segno di comando. Ragazzi e ragazze sono allievi del Conservatorio di Milano; è il 2 aprile 1905, il giardino è quello della “Società degli Artisti & Patriottica”, un sodalizio che aveva riflesso molte vivacità della Scapigliatura milanese.
Lì i giovanissimi musicisti hanno appena tenuto concerto; il ragazzo al centro ha diretto. Si chiama, all’anagrafe, Vittorio de Sabata. Ha dodici anni, perché è nato a Trieste il 10 aprile 1892. In conservatorio già stanno considerandolo un genio. Eppure ha in corpo tutti gli umori della sua età, non meno dei compagni. Voglia di muoversi, di far chiasso. Non soltanto con i fratelli, ma anche con i compagni di studio. Uno dei divertimenti preferiti è quello di unirsi ad un paio di amici, di appostarsi in classe d’organo accanto ad un allievo che sta suonando, finger di seguire guardando le pagine sul leggio, e di colpo buttarglisi addosso, facendolo scivolare sulla panca, sbattere per aria le mani e soprattutto puntellarsi in qualche modo con i piedi sulla pedaliera. Se il momento è scelto bene (un “fortissimo” con inserito il “tiratutti”), dall’organo uscirà una specie di urlo sgangherato, una dissonanza precipitante secondo le pedate scalciate dalla vittima; anzi, “una sghignazzata”. È questo il vocabolo esatto pronunciato dall’ex allievo de Sabata Vittorio, ora noto come Victor de Sabata, un pomeriggio del dicembre 1966, una sessantina d’anni dopo, nella sala-soggiorno a grandi vetrate dell’ hòtelclinica “Villa Attilia” sopra Santa Margherita Ligure. “Una sghignazzata, prosegue e insiste — “sembrava quasi che dentro a quello strumento ci fosse il diavolo. Altro che strumento sacro, di chiesa !… Per un attimo, il grande maestro, il musicista oceanico ha ritrovato l’ingenuità del ragazzo. Ma spesso i grandi sono anche così. E quel pomeriggio, nel parlare di strumenti e di rapporti acustico-musicali, a lui è tornata in mente quella ragazzata. Certo in quei momenti Vittorio-Victor dimenticava l’irrimediabile menomazione che la poliomelite gli aveva inflitto.
L’avrebbe sopportata poi da gran signore, che non permette ad altri più premure di quelle concesse alle persone normalmente efficienti. Lo stavo vedendo anche quel pomeriggio, nell’offrirmi il tè, ed era evidentissimo che non ammetteva di esser servito. L’avrebbe dimostrato non molti mesi dopo, con un gesto di indipendenza che gli sarebbe costato la vita.
Il conservatorio, gli studi. Non è molto noto che era figlio d’arte, suo padre Amedeo era musicista. La musica aveva avuto la meglio su altre passioni; una, fortissima, doveva esser nata vedendo, ancor bambino, a Trieste le navi grandi e piccole: l’inclinazione per l’ingegneria navale; ancora in età avanzata gli capitava di tracciare disegni nautici. Poi, trasferita la famiglia a Milano, il famoso scultore Troubetzkoy, vedendolo disegnare e notandone il gesto plastico delle mani, aveva ventilato l’idea di farne un futuro collega. Questo contatto con Paolo Troubetzkoy sembra connettersi alla sede di quel primo concerto alla
“Patriottica” e al suo ambiente di dieci-vent’anni prima e dopo, al divisionista Grubicy, a Segantini, ai suoi parenti Bugatti, dall’inventore di mobili artistici Carlo, allo scultore impressionista “bestiario” Rembrandt, a Ettore creatore di automobili da gara e da sogno a un livello che, conoscendo il Victor de Sabata futuro, verrebbe voglia di dir desabatiano.
Ma, si diceva, vinse la musica. E in conservatorio a Milano, Vittorio-Victor si era diplomato in composizione con i maestri Michele Saladino e Giacomo Orefice. La fama di piccolo genio gli veniva anche da una sua smania: quella di voler studiare non soltanto pianoforte e violino a livello solistico, ma di frequentare le classi di tutti gli altri strumenti imparando a suonarli tutti: i rimanenti archi, i legni dal flauto al fagotto, gli ottoni dal corno al trombone al basso tuba, l’arpa, i timpani, come se avesse speciale inclinazione per ciascuno.
A quei tempi, venivano invitati a dirigere l’orchestra degli allievi per i saggi alcuni dei maestri più in vista; e questi accettavano volentieri; è un po’ come se adesso Abbado, Chailly, Muti, Sinopoli dirigessero i saggi. L’aveva fatto Franco Faccio (nell’83, con il Capriccio sinfonico di Puccini); tra il 1905 e l’ 11 , venne a dirigere gli allievi Arturo Toscanini, ormai famoso. In quelle occasioni il direttore del conservatorio, Gallignani, chiamò in orchestra anche il dotatissimo allievo de Sabata e gli affidò una prima volta i piatti e la batteria, una seconda volta i timpani: sono strumenti ritmici, se si sballan quelli si può mandare all’aria tutto; il più sicuro nel ritmo era l’allievo de Sabata, l’incarico pareva modesto, ma era invece del massimo impegno.
In seguito l’aver imparato a suonare tutti gli strumenti gli avrebbe permesso, come direttore, una competenza e un’autorità non comuni. Avrebbe potuto chiedere un dato effetto e dimostrare lui stesso come ottenerlo; e questo avvenne infinite volte. Ma per noi, oggi, questo ha anche un altro significato. A quell’epoca la tendenza generale era quella di rendere il più possibile comodi e omogenei gli strumenti d’ogni famiglia; se fosse stato possibile, avrebbero applicato ad ognuno una tastiera tipo pianoforte. Era un grosso errore: i limiti e le difficoltà di ciascuno strumento corrispondono anche a caratteristiche preziose, sono parte della “personalità” di ciascuno; eliminarle li avrebbe impoveriti.
Lo si capì più tardi; ma de Sabata l’aveva intuito già allora, e andò controcorrente. Anche in questo, lo sorresse il gusto per la tecnica che inizialmente aveva rivolto alle costruzioni navali. E quando, passata la metà del secolo, incontrò gli
apparecchi di registrazione su nastro a più piste sovrapponibili, la sua musicalità, unita al saper suonare violino, viola e violoncello gli permise di registrare da solo un quartetto di Beethoven (chi possiederà, adesso, questo emozionante documento?).
Par chiaro che fin da quegli anni si stava delineando nell’allievo de Sabata una di quelle nature musicali che il lessico e la fantasia, entrambi poveri, cercano di definire chiamandole mostruose; di fronte a simili casi, nasce il dubbio: forse i veri musicisti sono soltanto loro, tutti gli altri che ritengono di esserlo e che hanno le normali carte in regola dovrebbero cambiare mestiere; anche molti che hanno il cosiddetto “orecchio assoluto” e ottima memoria.
L’attrezzatura iperbolica di Victor de Sabata si sarebbe rivelata sempre più chiaramente in futuro. Ma, sebbene fosse specialmente adatta a una carriera direttoriale, e malgrado l’esordio di dodicenne alla “Patriottica”, il suo possessore sembrava invece più interessato alla carriera del compositore. Già nel 1909, prima del diploma, il suo saggio, Suite per orchestra, aveva fatto scalpore; l’aveva diretta lui stesso; ma piacque, tanto che venne messa in programma a Roma nei concerti sinfonici di Santa Cedila; e ancora nel 1916 la avrebbe diretta, con l’orchestra della Scala in Conservatorio, un. grandissimo maestro, Antonio Guarnieri: incastonata tra la Settima di Beethoven e la Seconda di Brahms, due capolavori e due cavalli di battaglia di quel magnetico direttore. Nel ’10, a fianco del diploma de Sabata ormai non piú allievo sfornava anche due Ouverture. Si parlò di filiazione straussiana.
Dal 1910 al ’16 gli anni son pochi. Nel ’16 Victor de Sabata decise di affrontare l’opera. La temperie dannunziana era tuttora accesa; anche il libretto scelto, di Alberto Colantuoni, ne era parte. Si intitolava Il macigno. Tre atti. É il dramma dell’odio tra due villaggi di montagna. Ci si mescolano tracce di Romeo e Giulietta, della Figlia di Jorio e della Wally: Shakespeare, d’Annunzio, la baronessa von Hillern mediata da Illica. Driade e Iberto, ciascuno nato in uno dei due luoghi nemici, si amano e fuggono insieme; per vendetta i compaesani fanno cadere dall’alto un masso enorme che li uccide. Stampato da Ricordi, Il macigno andò in scena al Teatro alla Scala il 30 marzo 1917. Fu lodato. Ma si fermò subito. Quel tipo di opera intrisa di sinfonismo non pareva fatta per i nostri teatri. Vedi il caso di Antonio Smareglia, un musicista che interessò de Sabata, anche se non lo diresse mai, sebbene lo desiderasse. Qualcuno diede la colpa al titolo (c’è anche chi bada a certe cose); e l’opera divenne Driade; ma non camminò ugualmente. Oggi qualcosa è cambiato (non abbastanza, però); varrebbe la pena di rimetterci le mani; di riaprire quella prima pagina, con i sei bemolli in chiave, e quei due accordi dissonanti, violenti seguiti da sommesse, cupe asprezze; e poi, attraverso eccessi e dolcezze, grida corali e invocazioni e catastrofi, giungere al finale la bemol maggiore “dolcissimo”, velato da un’impressionistica sfumatura.
Il successo doveva arrivare in campo orchestrale. La tentazione del poema sinfonico era ancora forte; lo stesso Richard Strauss ne componeva ancora; nei programmi dei concerti appariva ancora la raffinata Procession nocturne di Henri Rabaud. Nel 1919 de Sabata mise in carta Juventus. E Toscanini glielo diresse in Italia e in America, e tenne a battesimo anche Gethsemani, “poema contemplativo” del 1925. In mezzo, era nata La notte di Platon (1924). Questi tre poemi sinfonici parvero presentare un compositore affascinante. Anche se si parlava di straussismo per Juventus e di “parsifalismo” per Gethsemani (facile, troppo facile, attaccarsi ad un inciso di cinque note, non udendo che il ritmo diversamente accentato lo allontana dall’ Incantesimo del Venerdì Santo). “Scende la sera sull’Orto Santo,” inizia il testo letterario scritto dallo stesso de Sabata; e non chiedeva poco al de Sabata compositore: “…la stellata immensa trasale e converge lente piogge d’astri verso la terra santa…
Il firmamento è tutto un abisso rutilante d’universi, una immensa promessa divina…”.
Tra Juventus e Gethsemani, La notte di Platon non chiedeva certo di meno; lì de Sabata si rendeva debitore verso un testo ancor più esigente, tratto da I grandi iniziati di Edouard Schuré, con qualche intenzione allusiva ai poteri superiori della musica, secondo una concezione che, nata nel Prologo dell’Orfeo di Monteverdi (“Io la musica son”), era nuovamente sbocciata presso i Romantici e aveva poi trovato una esaltazione “per contrarium” nei drammi di Wagner, che in teoria voleva la musica ancella della poesia, ma come nessun altro l’aveva creata regina. “… rinunzio anche alla poesia, perché ho riconosciuto che essa è incapace d’esprimere la verità quale io miro” .. . ; e Platone (anzi Platon: il clima dell’epoca amava ancora queste estetizzanti ricercatezze) dà fuoco a tutte le sue opere poetiche, mentre “una gran pace riempiva tutto il suo essere…”.
In quegli anni, però, era già avvenuta la grande rivelazione. Dal compositore de Sabata ormai lanciato (così sembrava) era balzato il grande direttore.
Suo padre Amedeo era stato assunto come istruttore dei cori all’Opéra di Monte Carlo, nel teatro-bomboniera annesso al Casino, puro (o impuro?) stile Garnier; nel 1918, Amedeo de Sabata ottiene per il figlio Victor il posto di direttore stabile dell’orchestra. E non solo “dell’orchestra”: nell’opera il direttore concerta e dirige, appunto, il totale musicale; non è un semplice accompagnatore, “dirige l’opera”, insomma (purtroppo, ancor oggi c’è chi non l’ha ancora imparato perfino a livello musicologico: una recente ponderosa storia dell’opera in più volumi ignora, tra le componenti basilari, appunto i maestri direttori).
È l’occasione perché trovino realtà le tendenze di Victor de Sabata ad esser padrone di tutta la musica, in ogni strumento, in ogni voce solista e corale.
La prima stagione che lo vede sul podio di Monte Carlo allinea tre delle opere che più tardi rifulgeranno nella sua carriera interpretativa: Tosca, Falstaff, La fanciulla del West, il Verdi più raffinato e due Puccini, più l’altro Puccini singolare de La rondine, che era nata qui nel 1917 diretta da Gino Marinuzzi. Quando de Sabata, molti anni dopo, dichiarerà che “la più elegante, la più raffinata partitura di Puccini è quella della Rondine” saprà bene di che cosa parla . Tosca sarà l’unica opera completa che de Sabata potrà lasciarci incisa in disco, e rimarrà un esempio impressionante e perfino rivelatore; le sue edizioni del Falstaff alla Scala faranno epoca, realizzando una nuova lettura-modello da affiancare a quella mitica di Toscanini; con La fanciulla del West de Sabata irromperà alla Scala undici anni dopo; in una interpretazione storica cui potrà paragonarsi soltanto quella di Dimitri Mitropoulos a Firenze nel 1954.
L’anno successivo, 1920, Monte Carlo ha da lui, oltre le riprese de La rondine, della Fanciulla e della Tosca, il Ponchielli da riscoprire della Gioconda, Puccini ancora con Butterfly, Montemezzi con L’amore dei tre re: un’opera che è troppo semplicista liquidare come “wagneriana”, fusione felice di sinfonismo e di canto italiano; sarà l’ultima opera che de Sabata dirigerà in teatro (alla Scala nel 1953).
Raoul Gunsbourg, il direttore artistico e impresario dell’Opéra di Monte Carlo, personaggio di spicco, aveva certamente buon fiuto; era abituato a scritturare lì celebrità vocali (in quegli anni, Gigli, la Dalla Rizza, Schipa, Battistini) e non (c’era appena stato Marinuzzi); chiamando de Sabata fece un incredibile en-plein; il futuro deve essergli grato fino a perdonargli di aver trasformato in opera La damnation de Faust di Berlioz. Tutti, anche i grandi, seguono un’evoluzione. Gli esordi di de Sabata non saranno stati ancora pari alle realtà di dieci, venti, trent’anni dopo. Anche lui avrà trovato qualcosa da imparare. Ma quando si è musicisti a quel livello “mostruoso”, imparare è ancor più immediato delle funzioni vitali. Gunsbourg dovette mostrare anche un certo coraggio. Già allora, il nuovo direttore doveva apparire diverso dagli altri; probabilmente il suo affondare come una lama la sua lettura, e forse i suoi estri, non piacquero a chi voleva starsene tranquillo. Soltanto cosi si spiega che a Puccini, prima della seconda ripresa della Rondine, qualcuno avesse insinuato che de Sabata fosse “un serio dolore” quando dirigeva. (Puccini ebbe modo poi di constatare che non era vero).
Gemma di quel periodo, la “création” o “prima assoluta” de L’enfant et les sortilèges di Maurice Ravel, che entusiasmò l’autore. Magia, delicatezza e humor: tutto de Sabata, anche il meno ovvio. Peccato che Ravel non abbia potuto ascoltare la sua Valse, flessuosissima e inquieta con il “suo” direttore a Salisburgo negli anni Cinquanta. A Monte Carlo, Gunsbourg lo trattenne per dodici anni, finché poté, finché gli altri impegni sempre più importanti e più lontani non gli tolsero il “suo” direttore principe.
….e nel 1921 sbocciò il direttore sinfonico. Almeno per quanto se ne sa (le cronologie sembrano esser lacunose.).
Sicuramente, troviamo Victor de Sabata a Roma, sul podio dell’Augusteo, con l’orchestra dell’Accademia
di Santa Cecilia, il 9 gennaio 1921: Mozart, ouverture del Flauto magico; Sibelius, Il cigno di Tuonela; de Sabata, Juventus; Franck, Psyché (Sommeil de Psyché, Psyché et Eros); Pick-Mangiagalli, Voci e ombre del vespero; Richard Strauss, Don Giovanni. Nemmeno cinque mesi dopo, era a Milano, sul podio della sala grande in Conservatorio con l’orchestra della Scala: Sinfonia di Franck, En saga (Una leggenda) di Sibelius (ne avrebbe lasciata una trasfigurata incisione), cinque Sonate di Scarlatti trascritte da Tommasini, il Till Eulenspiegel di Richard Strauss. Eclettismo nei programmi, poco stampo classico, almeno in apparenza. Molte esigenze di colore. Segni del gusto d’epoca, ma anche un desiderio di spaziare tra tavolozze cordiali, maestrie virtuosistiche di orchestrazione, concentrazioni romantiche.
Così si univano, anche visibilmente udibilmente il compositore e il direttore teatrale e sinfonico, nel totale del musicista. Non sappiamo se Victor de Sabata avesse letto Hoffmann. Le sue inclinazioni letterarie verso ascesi spirituali e immaginifiche — la Grecia ricreata da Schuré —potrebbero far posto anche a quel Romantico della prima ora. I grandi artisti spesso hanno, in determinati momenti, una particolare coscienza di sé e del loro valore; in parole semplici, sanno di essere bravi, molto bravi. Mi chiedo se a questo punto della sua vita di musicista Victor de Sabata non si sentisse simile ad una incarnazione del Kapellmeister Johann Kreisler immaginato da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Kapellmeister, direttore d’orchestra. Il termine tedesco si sarebbe deteriorato in seguito, fino a diventare anche un connotato negativo; ma a noi questo non deve interessare. Dobbiamo veder vivere Kreisler: “allievo di un buon maestro, perché suona in maniera straordinaria”, ma soprattutto è capace di far suonare e cantare gli altri, perché è direttore d’orchestra. Capace di far suonare perché sa suonare; perché è il musicista completo, ed è il musicista completo perché sa comporre, suonare e soprattutto far suonare. Questo è il succo della Biografia frammentaria del Kapellmeister Johann Kreisler, al di là delle mille fantasticherie, avventure, invenzioni, stravaganze dell’autore della Prinzessin Brambilla. Fantasia fantasticante; ma anche concezione della musica senza mai tralasciarne la tecnica (descrizioni di sedute musicali, precisando tonalità, ritmica, pause e persino uso dei pedali in certe improvvisazioni al pianoforte mai esistite…). Anche per de Sabata la tecnica contava molto, abbiam visto; quella degli strumenti e quella del gesto che appare incandescente e che tuttavia sa sottilmente comandare, guidare, imporre, far suonare. Biografia frammentaria: perché -immaginava Hoffmann — era stata mescolata agli scritti di un gatto, anzi gattone, il Kater Murr… Un gatto: Victor de Sabata amava moltissimo i gatti. Coincidenze. Ma quando si è eccitati da fantasie intense (gli impasti nella partitura di Juventus, l’atmosfera della Leggenda di Sibelius, l’attacco della Sinfonia in mi bemolle di Mozart — diretti da de Sabata, naturalmente — certe coincidenze diventano lampi di verità. Forse aveva letto Hoffmann l’autore di un curioso ritratto: aveva immerso il maestro in una atmosfera che, per voler essere, chissà, demonica (nel senso del dàimon, ente divino dalla Grecia in poi) scivola verso il demoniaco nel senso di diabolico: i primi Romantici e in particolare Hoffmann univano in immagine i due concetti. Però, a voler esser hoffmanniano e desabatiano, in quel dipinto ci sarebbe dovuto essere anche almeno un gatto.
Tra il 1921 e il ’29, Victor de Sabata prosegue nel suo lavoro stabile all’Opéra di Monte Carlo, Scorrendo i programmi, si trovano titoli di repertorio; e li ritroveremo tutti nei cartelloni dei grandi teatri dove in seguito sarà chiamato a concertare; ma se ne nota anche qualcuno che purtroppo non avrebbe più diretto. Immaginare il colorismo del Rismkij-Korsakov di Sadko ci è forse facile. Ma quale sarà stata la sua lettura dell’ironica Heure espagnole di Ravel, quali taglienti profili, quali avvolgenti allucinazioni, quali echi corali avrà offerto con lui il Musorgskij del Boris Godunov (poco importa se nella “traditrice” revisione Rimskij, lussureggiante invece che scarna; ha pur permesso che il Boris si rivelasse come un capolavoro); quale lusso di sensualità, di eleganze nostalgiche, di riflessi rari avrà reso prezioso il Rosenkavalier di Richard Strauss? Davvero, i teatri dove de Sabata non diresse questi capolavori hanno perduto qualcosa di irrecuperabile.
Nel 1929, de Sabata era ormai consegnato al giro internazionale dei concerti sinfonici. Roma, a Santa Cecilia, Milano con l’orchestra scaligera nelle sue diverse sedi (il Piermarini, il Conservatorio, l’ex-capannone Brown-Boveri diventato auditorium del “Teatro del Popolo” per la Società Umanitaria), lo hanno rivoluto e riacclamato, sui podi che hanno ospitato tra gli altri, il mitico Nikisch, Toscanini, Guarnieri, Bodanzky, Marinuzzi, i “giovani” Scherchen e Furtwängler. E poi Trieste, Bologna, Venezia, Parigi; infine, da settembre a dicembre del 1927 New York e Cincinnati, con due tra le più famose orchestre del mondo.
Anche nella sfera intima, la persona di de Sabata viene completandosi: nel 1923 aveva sposato Nori Rossi; appunto nel 1929 nasceva il primo figlio, Elio. Nome solare; non meno solare sarebbe stato il nome donato alla figlia, nel 1934: Eliana.
Il 1930 Victor de Sabata l’aveva iniziato a Parigi dirigendo concerti. Probabilmente sapeva già quale nuovo spazio gli si apriva: la Scala tutta intera, oltre l’orchestra che già conosceva e che aveva già dominato.
Toscanini aveva lasciato il comando scaligero. Aveva creato la Scala del “decennio d’oro”, modello del teatro d’opera moderna, con l’Opera di Vienna di Gustav Mahler. Non intendeva aver più sulle spalle il fardello di un teatro con i suoi tanti problemi; e nemmeno intendeva più dirigere opere; avrebbe fatto eccezione soltanto per i festival di Bavreuth e di Salisburgo. A New York lo attendeva la Filarmonica che lo aveva nominato direttore stabile.
Negli anni recenti aveva ascoltato dirigere de Sabata; non sempre doveva essersi trovato d’accordo con la linea delle sue interpretazioni; ma del loro livello artistico, della sua insolita personalità di musicista e di direttore era certamente convinto. Per questo volle che alla Scala ci fosse de Sabata.
L’8 dicembre 1930 andava in scena, diretta da lui, La fanciulla del West con la Dalla Rizza, Thill, ViglioneBorghese. Ci sono ricordi unanimi nel definirla emozionante. Anche quelli di chi a quell’epoca era ancora bambino, sia pure un bambino che udiva far e studiar musica in casa, che ne era attratto e che ascoltava alla radio le prime “dirette” di concerti e opere. Tra quei ricordi uno è vivissimo: il ritmo scattante nitidissimo degli “Hello, Minni!” sul folgorante tema di lei, al primo atto.
10 aprile: Scala, La dannazione di Faust. 11 dicembre, Scala, Tristano e Isolda, con Giuseppina Cobelli, Renato
Zanelli, Ebe Stignani. Ovvero, l'”esplosione”. Oggi si obietta subito: in italiano? con i tagli? ma Wagner stesso (come anche Richard Strauss) intendeva che le sue opere si dessero nella lingua del luogo… forse anche lui si era accorto che soprattutto contava la sua musica, pur contraddicendo le sue idee sul Wort-Ton Drama; ma non riapriamo, assieme ai
tagli (peraltro in parte disposti da Wagner stesso), anche certe discussioni.
E certo che fu un inatteso, inaudito (nel senso di non ancora udito) lucidissimo turbine, capace di travolgere senza confondere, di ammorbidirsi senza intorbidarsi, di esser folle e catartico. In orchestra, subito ci si stupì per lo struggente “effetto-sospiro” alle battute 25-26 del preludio; lo ha scritto Wagner, facendo scendere i primi violini dal do diesis nel rigo a quello centrale, mentre le viole scendono dallo stesso do diesis al re, raggiungendolo un ottavo dopo, in una soave dissonanza; con de Sabata, risultava nitidissimo, ma struggente come non mai.
Quel preludio si era aperto, nel celebre tema dei celli che fa sbocciare il “Tristanakkord”, con una misteriosa mobilità della misura, che appariva esatta e al tempo stesso fluttuante; il famoso “rubato udibile ma inesistente” di Toscanini trovava una nuova dimensione. Con simile intensità, il Tristano era passato attraverso momenti ciclonici e soavità inquietanti (al terzo atto, il ripetere dolcemente ebbro dei quattro corni soli l’inciso discendente, di tre sole note, sol diesis-mi-la diesis, miraggio dell’atto precedente), o trasumanate nello stupore lacerante (“Odo la luce…”); fino alla trasfigurazione di Isolda, non incalzante come spesso si era udita — non è più l’ebbrezza del secondo atto, questa — ma composta come un’apoteosi catartica nobilissima. C’è una descrizione molto efficace del Tristano desabatiano nel libro che Teodoro Celli ha dedicato al maestro.’ I ) Rinvio a quella e rinvio a me stesso, che nel ’30 non avevo potuto saperne nulla, per Tristani successivi, quello del 1947 (in tedesco, ormai), con la Flagstad e con un vitreo tenore svedese Beyron che ancora in prova generale de Sabata cercava di render più vivo (spesso interveniva in scena, accanto al regista); e ancora nel 1948 e nel 1951, con la Flagstad e Lorenz, poi con la Grob-Prandl. Al testo originale tedesco si era convertito non soltanto perché le idee, intorno, si evolvevano in quel senso; nel 1939, unico italiano oltre a Toscanini, de Sabata aveva diretto al festival di Bayreuth nel teatro ideato da Wagner; una inimitabile struttura acustica per un interprete inimitabile. Con Tristano e Isolda, naturalmente.
Tristano è stato visto come il centro nell’esperienza di de Sabata, come il culmine di quanto ha realizzato. Ma questa non dovrebb’essere materia di primati. Intanto, il de Sabata musicista continuava a essere anche il de Sabata compositore. Proprio in quel 1930 che gli aveva aperto le porte scaligere, un lato del suo umore creativo meno noto gli aveva dettato una curiosa impresa, la musica per un balletto intitolato Mille e una notte. Il titolo non inganni: la vicenda (scritta da Giuseppe Adami) è ambientata a New York in quello stesso 1930; inizia nella centrale telefonica della metropoli, tra le telefoniste; c’è di mezzo, sì, anche uno Scià orientale, ma alla fine costui parte su un gigantesco idrovolante; la musica svaria e si scapriccia in bizzarre armonie complesse, in accenni orientali e in occidentali sofisticate danze, con una magistrale tavolozza molto novecentesca; è una sorta di pastiche art-déco, e in fondo anche un omaggio alla grande New York 1930 come suggerisce la copertina, dove una specie di “Do. X” (appena costruito da Dornier allora) sorvola il Chrysler Building
(costruito da poco anche quello), il più bel grattacielo del mondo con la sua cupola déco. La grande New York e gli USA che de Sabata aveva cominciato a conquistare dirigendo concerti, nel 1927. Mille e una notte andò in scena alla Scala nel dicembre 1931; ballava la star Cia Fornaroli, dirigeva Ferruccio Calusio.
Questa singolare partitura, assieme ad alcune pagine pianistiche su movimenti di danza moderna, ci dice con certezza che dirigendo a Monte Carlo La rondine di Puccini con i suoi fox, tango e one-step, oltre ai valzer, de Sabata seppe dar loro il giusto carattere e la giusta ironia (quando Puccini ebbe a lagnarsi delle esecuzioni che avevano “appesantito tutto”, parlava delle “esecuzioni italiane”: “…se non avessi sentito io a Monte Carlo, direi che ho sbagliato. . .”: a Monte Carlo, da Marinuzzi ma anche da de Sabata). Eppure molti, ancor oggi, vedono in lui soltanto il direttore del Wagner e dello Strauss più ambiziosamente grandiosi.
Appena quattro anni dopo, Max Reinhardt allestì Il mercante di Venezia di Shakespeare appunto a Venezia in Campo San Trovaso, e chiese a de Sabata di comporre le musiche di scena. Lo spettacolo del grande regista si rappresentò dal 6 luglio 1934, con le musiche desabatiane.
Dopo il ’34, non apparve più nessuna composizione sua. Eppure si sa che abbozzava, tentava, prendeva appunti: se ne son trovati parecchi tra le sue carte. Ne ricordo uno, scarabocchiato sul margine di un giornale: c’erano accordi complessi e un disegno di note in valori quasi pulviscolari, le parole “febbre, malattia, insetti”. Si sa che aveva intrapreso a comporre una Lisistrata, sul sarcastico soggetto di Aristofane, illustrato da Beardsley; anche questo confermerebbe le sue visuali, tutt’altro che limitate alle esaltazioni saperne. Se anche ci lavorò, non la terminò mai; finora non si è trovata traccia riconoscibile.
Si diceva del Tristano come centro e come culmine. Ma non è il solo. Le cronologie, sebbene a volte siano incomplete, ci mostrano de Sabata in grandi tournées americane con la Philadelphia Symphony (1952), con la Chicago Symphony (1949), con la Boston Symphony (1950) con la London Philharmonic; ospite dei Berliner Philharmoniker (con essi ci ha lasciato dischi preziosi), della Filarmonica di Vienna, delle Filarmoniche di Praga e di Budapest, oltre che con i complessi della Scala e di Santa Cecilia, in trasferte sinfoniche e operistiche, a Vienna, in Germania e in Inghilterra. Oltre, com’è naturale, nelle stagioni alla Scala, a Firenze, a Roma. In questa vasta attività alcuni momenti sembrano emergere. Vediamo.
Il ciclo completo delle Nove sinfonie di Beethoven: a Londra nel 1947 nell’Alberi Hall immensa, con file di attesa notturne del pubblico, e alla Scala, nel 1952. Furono occasioni per momenti di altissima comunicazione. Certi passaggi — ad esempio nella Quinta lo sfociare emozionante dallo “scherzo” al finale, con una tensione misteriosa liberata in grandiosità insolitamente ampia — rimangono fissi nella memoria di chi poté ascoltarli. Eppure fu quella una delle occasioni in cui una parte della stampa milanese più o meno competente rivolse a de Sabata pesanti attacchi. Lo si accusava di snaturare la classicità di Beethoven, di volerlo rendere più suggestivo e impressionante di quanto non dovesse essere. In particolare qualcuno (i tuttologi esistevan già allora) arrivò a scrivere che in quel Beethoven “l’orchestra giordaneggiava”, e non voleva essere un complimento; tantopiù che lo stesso qualcuno, quando de Sabata aveva diretto opere di Umberto Giordano – Chénier o Fedora —, si era abbandonato a dire che gli “eccessi” desabatiani avevano dato un’impressione simile a quella che darebbe un fuoribordo al quale si fossero applicate le turbine di un transatlantico. Fu allora che Giulio Confalonieri scrisse un articolo di fuoco, dichiarandosi autorizzato a parlar di musica essendo musicista e discendente di musicisti ben più di chi, di musica ignaro, insultava le interpretazioni beethoveniane di de Sabata, mentre si trattava di veggenti, esaltanti aperture sugli abissi e sulle illuminazioni che di Beethoven sono la cifra più vera e genuina.
Il Verdi scabro e geniale del Macbeth; quello evolutissimo dell’Otello e del Falstaff. Nel 1952 alla Scala, con Maria Callas, agghiacciante “Lady”, Muscherini e Tajo, de Sabata trasse bagliori sulfurei da un Macbeth nervoso, asciutto, inquietante; in Otello (Firenze, Maggio Musicale 1937, e Milano, Scala 1938 con Merli, Stabile; ancora Scala, 19471949, con Vinay, Bechi, la Caniglia prima, la Tebaldi poi), scolpì un dramma di tempesta e di presaga calma notturna, di luci e ombre; nel Falstaff, alla Scala 1950, con il sir John più famoso, Mariano Stabile, giocò la commedia tra scena e orchestra (e in orchestra) con una presenza quasi parlante; nella pur non felice registrazione carpita in teatro, quel rilievo vivissimo colpisce e stupisce.
Brahms, e soprattutto la Quarta, aperta con un cantare di archi talmente intenso, da parer che stessero già suonando da chissà quanto, e chiusa da una passacaglia robusta e slanciata come un’arcata gotica, con un secondo tempo esalato da nebbie crepuscolari.
Jeux di Debussy, eseguito con l’orchestra romana di Santa Cecilia nel 1946, portato nei concerti di tournée con questa orchestra — che fu molto “sua” — attraverso l’Italia e l’Europa (undici concerti); è una partitura troppo poco nota, del 1912, raffinatissima e concepita con criteri strutturali basati sul ritmo e sul timbro nuovi anche per Debussy; avrebbe sollevato stupore ammirato presso le avanguardie quando, più tardi, la diresse Pierre Boulez, ignari tutti che allora l’avesse diretta e incisa in disco — e a quale livello — l’”estraneo” Victor de Sabata; una prova in più, se occorresse, di quanto fosse versatile e moderno.
Più tardi, negli anni del forzato riposo a Santa Margherita Ligure, conversando con i suoi rari ospiti, il maestro ricordava quel suo rapporto con l’orchestra romana come un momento molto positivo. Peccato — soggiungeva però — che ormai non ci fosse più l’Augusteo, distrutto dalle smanie fasciste di romanità, ridotto ad un triste rudere cariato; e qui, un sorriso quasi sbarazzino gli correva in viso: “Ma adesso che non comandano più loro, in fondo si potrebbe ricostruirlo; come Augusteo-auditorium, dico, non come mausoleo. Lo proporrò”.
Mozart, Sinfonia in mi bemolle maggiore (K.543), ovvero: quando il “dionisiaco” dimostra di essere anche il più “apollineo”. Probabilmente, Nietzsche scrivendo La nascita della tragedia non immaginava quale cattivo uso di sarebbe fatto di quei principi espressivi, ridotti ad etichette e a luoghi comuni. “Dionisiaco”, come etichetta appiccicata a de Sabata, stava molto al di fuori di quanto e di quando fosse dionisiaco davvero. Ma quanto fosse anche apollineo, a dirlo bastava la sua interpretazione della Mi bemolle di Mozart; bastava, anzi, ascoltarne l’attacco dell’introduzione “adagio” : non pomposo, predicatorio e pesante, ma trasparente, luminoso (solare, come i nomi dei due figli del maestro), appena poco più mosso della tradizione, con il ribattere “puntato” del timpano non cupo, vibrante di luce classica. Ma già: per l’etichettatura più diffusa, de Sabata sarebbe “dionisiaco” quanto Toscanini era “apollineo”; ebbene, si ascoltino, con Toscanini, le ultime battute del primo atto della Valchiria non nella solita incisione del 1941, ma nell’altra meno nota del 1947, dove si può confrontare la prova generale con la esecuzione pubblica, ben più accesa: è difficile trovarne una lettura più “dionisiaca”, molto vicina, per carattere e per fremere di corni, a quel che ne faceva de Sabata (Scala 1949).
Meno apollineo risultò un altro Mozart, quello del Requiem, quando de Sabata lo diresse nel 1941 a Roma in Santa Maria degli Angeli, in una versione gigantesca, con i complessi orchestrali e corali radiofonici dell’allora EIAR riuniti, solisti la Tassinari, la Stignani, Tagliavini, Tajo. Fu un avvicinare questo Mozart estremo e non tutto autentico al Requiem corrusco di Verdi, diretto là un anno prima, con i medesimi complessi se non altro per averlo portato nello stesso immenso ambiente e con analoghi mezzi fonici sebbene ben diverso sia l’organico delle due partiture; l’acustica della chiesa medesima agì anch’essa da elemento avvicinante; e anche lo spettacolo grandioso.
Pelléas et Mélisande (Scala 1949 e 1953), ovvero il fascino del flou portato all’estremo e tramutato poi in vibrazioni inquiete (ultimo interludio del quarto atto) e in commozione stupendamente penetrante ed estenuata (finale).
La memoria, l’orecchio… Si vorrebbe evitar di parlarne, è l’argomento più ovvio quando si tratta di grandissimi direttori. Ci sono doti mnemoniche in sé stupefacenti, addirittura indipendenti dalla durata dello studio (e, talvolta, anche dai risultati). A Guarnieri bastava leggere una partitura per averla tutta in mente (e per trarne miracoli, con quel suo gesto minimo e con le poche prove che concedeva); a Sergio Failoni una memoria di tipo fotografico stampava in testa una partitura soltanto avendola sfogliata.
Difficile dire quanto tempo durasse. A Toscanini durava, pare, decenni, una vita. Anche a de Sabata. E non soltanto per le musiche studiate e dirette. Anche per altre conosciute per caso e addirittura insignificanti. Nel gennaio del 1939, de Sabata diresse all’Opera di Roma una Butterfly, con Licia Albanese e Ziliani; a una prova di sala, durante una sosta, de Sabata sedette al pianoforte lasciato libero dal maestro sostituto, suonò qualcosa di indeterminato, si interruppe e al sostituto chiese: “Di’, te lo ricordi?”. L’altro, meravigliato, rispose che no, quello spunto non gli rammentava niente.
De Sabata riconminciò da capo a suonare, proseguì, completò il brano ignoto; e insistette: “Ma davvero proprio non te lo ricordi? “. Nuovo diniego, sempre più stupito. E lui “…ma è il tuo saggio di conservatorio per il diploma in composizione! ” Roba di almeno trent’anni prima, oltre a tutto. Da mettere vicino all’essere in grado di riscrivere partiture di Wagner come Stravisnki o di Tommasini; bastava indicargli quale pagina si volesse vedere riscritta a mente, fino all’ultimo colorito, pausa, accento.
L’orecchio. Provando alla Scala il primo atto della Valchiria, alla prima arpa: “Ho sentito un fa bemolle invece di un fa naturale; o ha la corda che cala o ha giù il pedale sbagliato! ” (Inutile rammentare che de Sabata sapeva suonare tutti gli strumenti).
Signorile sempre, anche quando rabbuffava qualcuno in orchestra sembrava più paterno che despota. Voleva vedere bene tutti: “…non lo vedo, non lo vedo! O cambia sedia, o abbassa il leggio! “. Orchestrali e coristi, spesso, erano ‘ragazzi’: “Qui, ragazzi, dovete partire come fulmini! “. O più semplicemente: “Suonate, ragazzi!”.
Eppure nessuno più di lui dominava con la sicura certezza di sapere e di volere.
Sembrava sofrire fino allo spasimo; epure riusciva anche a provare certe sensazioni perfin divertenti proprie del far musica insieme. Accompagnare un solista capace di vrituosismi acrobatici con “tempi” ultrarapidi, spinti in un dinamismo che pure significa qualcosa al di là della bravura, può avere il gusto della gara; tanto da suggerire, a esecuzione finita, battute da ragazzi: “Speravi di scapparmi, ma hai visto, non ti ho mollato mai! “.
Terminata un’opera, alla ribalta con i suoi cantanti, fosse stata l’Aida, la Valchiria, il Falstaff, il Sansone, la Salome, la Bohème, o il casereccio Mefistofele, nel sorriso di de Sabata spesso c’era il riflesso di un piacere provato.
Il gesto. Anche di quello si è parlato moltissimo. Lo si è trovato “danzante”, “travolgente”, “misterioso” e via descrivendo. Certo, gesto e mimica in de Sabata erano personalissimi e incredibilmente vari. Poteva emanare una calma olimpica, distesa, adatta a ben sostenere tempi larghi e modellare sonorità eteree qualche volta plasmandole senza bacchetta; più tipico sembrava a tutti il suo scatenarsi, in veri raptus dove sembrava di non distinguere più nessun segno di ritmo, di accento, di entrate; eppure anche lì si nascondeva una tecnica di mano, di braccio, di polso, capace di virtuosismi semantici che anticipavano le entrate; una mimica facciale dal feroce al trasumanato all’attento al minuzioso; non era facile seguirlo, soprattutto quando improvvisava sfumature, coloriti, “allargando” e “stringendo” diversi che in prova. Ma i risultati, quei risultati che stupivano, eran lì a dimostrare come fosse infinitamente più produttivo rischiare con lui che seguire placide e insulse battute d’altri. Le fotografie si compiacquero di mostrarne atteggiamenti, espressioni di una maschera mobilissima; insistettero forse troppo, volendo fare di lui uno spettacolo. Poteva accadere che lo fosse; ma c’era sempre una suprema ragione comunicativa. Spossante, certo, questo dirigere, non risparmiandosi mai, nella stessa misura, nelle prove quando era solo con i suoi esecutori, e quando dietro di lui c’era il pubblico, con le sue tensioni, le sue attese, le sue distrazioni. Veder dirigere un grande maestro, vederlo anche in viso come lo vedono orchestrali, coristi, cantanti, dà sempre qualcosa.
Tantopiù in un grandissimo come de Sabata, soprattutto per come lui era.
I miracoli; o meglio, il giusto. La simpatica cantata San Giuvanni Latterano di Pietro Clausetti, appena sfornata nel settembre 1951 alla radio con un altro direttore, sembrava rammentare troppo, con il suo a-solo di flauto dell’inizio, l’Après-midi di Debussy. Giorni dopo, alla Scala con de Sabata, da quell’a-solo ogni traccia di Debussy e dell’Aprèsmidi era sparita, quel flauto aveva trovato la sua voce giusta e il suo giusto charme.
Un ultimo miracolo: il de Sabata pianista. Diversamente da Mitropoulos, che pure era un pianista strepitoso, non aveva mai suonato in pubblico da concertista. Eppure aveva sotto le dita, con padronanza assoluta, gran parte del repertorio, anche virtuosistico. Oltre, naturalmente, al saper trasferire magistralmente sulla tastiera qualunque pagina sinfonica. A memoria, si capisce. Se gli capitava a tiro un pianoforte, difficilmente resisteva alla tentazione di provarlo: con una Rapsodia ungherese di Liszt, con uno Studio di Chopin, o con pezzi “da sesto grado” come Scarbo da Gaspard de la nuit di Ravel, che l’autore definiva “plus difficile qu’Islamey“. Ma appunto Islamey di Balakirev, una specie di super-Liszt orientaleggiante, gli piaceva di adoperare, per tenere in esercizio — diceva — determinate dita. Avveniva che la padronanza pianistica sommata alla sua attrezzatura di musicista sortisse episodi curiosi; come quando, capitatogli sottomano un pianoforte piuttosto malandato, e saggiatolo con uno Studio di Chopin, tentò ripetutamente di non trovare tasti inceppati trasportando il pezzo in tre o quattro tonalità diverse, con identica facilità, nelle ben diverse disposizioni dei tasti.
In tournée con la Scala all’estero. E quale estero. Per la Scala, era ormai un vizio quello di sfidare il pubblico agguerrito, esigente e “classico” dell’area germanica. L’aveva già fatto Toscanini nel 1929, prima di abbandonare la direzione della Scala, quasi a cercare un avallo europeo all’impronta artistica esemplare che aveva dato alla Scala, vera lezione di modernità e di approfondimento. Nientemento che a Vienna, dove un’analoga lezione aveva dato Gustav Mahler, anche lui votato a superare il pressapoco operistico con una lettura globale, anche scenica, imperniata sulla esattezza musicale, per quanto estrosa.
I viennesi si entusiasmarono per Falstaff e stupirono per Lucia, che sembrò loro un’opera nuova. Lo stesso era avvenuto a Berlino, con Falstaff, Rigoletto, Lucia, Trovatore, Manon Lescaut, Aida.
Con Victor de Sabata, la Scala aveva rinnovato l’impresa germanica, quasi a dimostrare che a quel livello, ammirevole anche se ormai non più ignoto, un’altra mente e un altro interprete potevano giungere, e avere una parola da dire: nel 1937, a Monaco di Baviera e a Berlino, de Sabata portò il Requiem di Verdi, il suo apocalittico e commosso Requiem, La bohème, Aida.
Dopo aver associato Alceo Galliera in una breve trasferta di concerti scaligeri in Svizzera (Lugano, Zurigo, Basilea) nel 1947, anche nel 1950 de Sabata non volle esser solo portando i complessi della Scala in Gran Bretagna; ebbe con lui Guido Cantelli e Franco Capuana come direttori; a presentare la musica italiana contemporanea in un programma di Cantelli, si scelse il Concerto dell’Albatro per trio, orchestra e recitante, dal Moby Dick di Melville, di Giorgio Federico Ghedini, solisti Ornella Puliti Santoliquido, Arrigo Pelliccia, Massimo Amfitheatroff, trio celebre. Dovette essere una partenza in buonumore, stando alla foto dove, alla Stazione Centrale di Milano, vicino al wagon-lits, Ghedini, impenitente umorista e dotato del physique-du-rôle adatto, si finse suonatore ambulante cieco, spalleggiato dalla zingaresca pianista Ornella, mentre de Sabata e Cantelli gli facevano l’elemosina.
Quella tournée a Edimburgo e a Londra, dal 4 al 24 settembre, fu una vera e propria stagione. De Sabata diresse il Requiem di Verdi, Otello e Falstaff oltre a un programma che si apriva con la Quarta di Brahms e si chiudeva con la seconda suite del Daphnis di Ravel. Ma a Londra aggiunse due concerti con la London Philharmonic (1-3 ottobre). E dal 27 ottobre al 19 novembre, traversato ancora una volta l’Atlantico, era a Pittsburgh per sei concerti, e ancora il 24 con L’enfant et les sortilèges.
Eppure i126 dicembre apriva la stagione alla Scala, dirigendo l’Otello.
Se si prosegue leggendo quel che seguì, nei tre anni successivi, tra Scala, New York, Filadelfia, altre sedi in USA e in Canada, Roma-Santa Cecilia (con tournée), di nuovo la “London”, Los Angeles, San Francisco, Vienna (Filarmonica), tutte orchestre splendide a cominciare dalla inimitabile Wiener, ma molto differenti tra loro, se si
prosegue a leggere, dicevo, si può comprendere quale sia stata la gloriosa, macerante, distruggente preparazione alle irrimediabili crisi cardiache del 1953.
I gatti. Li amava moltissimo; se poteva tenerne in braccio uno e accarezzarlo, o giocarci, era felice. Ma i gatti ci portano a ricordare gli ultimi anni di de Sabata, i quattordici anni di esilio, volontario e forzato insieme, a Santa Margherita Ligure.
Mentre ancora stava incidendo la Tosca tuttora considerata storica, aveva sentito avvisaglie della crisi cardiaca che sopravvenne. Era l’agosto del 1953; messo a riposo, si trasferì a Santa Margherita in hôtel; altre gravi crisi lo costrinsero in clinica a Rapallo per mesi. Ne uscì convinto di non dover più dirigere; non sopportava di rischiare crisi in presenza di gente, suscitando scompiglio, apprensioni, curiosità.
Nel 1954 si era rimesso; ritornò a Milano, alla Scala. Volle ancora incidere il Requiem di Verdi, “anche per dimostrare che sono vivo”. Tornato a Santa Margherita, visse là, praticamente solo, spostandosi ogni tanto da un hôtel all’altro. Il più caratteristico era senz’altro il Metropole, sulla discesa di fronte all’Imperiale; era gestito da persone civili, colte e spiritose (“Tarde venientibus, ossa”, stava scritto sotto la tabella degli orari in sala da pranzo). Là leggeva, studiava, abbozzava composizioni; in camera aveva un piccolo pianoforte a coda, sovraccarico di fogli, spartiti, partiture; libri e giornali erano ovunque. Allora l Metropole aveva interni che somigliavano più a una casa borghese vecchiotta che a un albergo. Lì venivano a trovarlo i dirigenti del Teatro alla Scala (era stato nominato dapprima Sovrintendente artistico, poi Alto Consulente artistico, incarichi creati apposta per lui, e gratuiti), amici musicisti e non.
Quando, terminata la visita, il maestro usciva per accompagnare gli ospiti all’autobus, dopo pochi dei suoi purtroppo faticosi passi veniva seguito prima da uno, poi da due e infine da tre gatti, che a coda alzata gli facevano corteo; amici suoi, era evidente. Quella sua solitudine colpì Francis Poulenc, che era andato a trovarlo con Giulio Confalonieri. Partito il bus, dopo un momento il compositore francese ebbe un sussulto ed esclamò, smarrito: “Mais maintenant… ce soir il restera seul…” . Al Metropole, la sera del 31 dicembre si faceva portare in camera lo champagne; a mezzanotte, telefonava in direzione, e al telefono augurava e brindava.
Nell’estate del 1967, sposatasi la figlia Eliana con il giovane direttore d’orchestra Aldo Ceccato, lasciò Santa Margherita per una “vacanza” con loro a Gavarno, luogo di villeggiatura della famiglia.
Si spostava a volte guidando una Mercedes con il cambio automatico, che gli permetteva di non usare la frizione. Proprio quell’automobile favori la sua fine. Era inverno. A volte anche in Riviera la temperatura si abbassa improvvisamente, fino a gelare. Avvenne anche in quel mese di dicembre; il maestro stimò necessario far mettere l’antigelo nel radiatore della Mercedes. Ma, come sempre, non volle che altri si disturbasse; uscì lui, con l’auto. Quel freddo e la sua signorilità gli furono fatali.
Con lui, andando a fargli visita, si parlava —naturalmente — di musica. Ad esempio, dei ritocchi alla orchestrazione di autori anche grandissimi; li hanno sempre praticati tutti i grandi direttori. Trovava assurdo fermarsi a certi limiti che avevano costretto, per esempio, Beethoven, a non poter scrivere certe note che allora gli strumenti non avevano. “Dobbiamo saper capire che cosa voleva Beethoven, dove era soddisfatto di quel che aveva a disposizione, e dove no”.
Filologia molto più sana di quella che oggi circola, tutta preoccupata di riavere materialmente un “suono originale” che originale non può essere, perché l’udito e il non-silenzio sono quelli odierni. Non trovava contrastante il fatto che coesistano strumenti a suono fisso accordati secondo la scala temperata (pianoforte, organo) e strumenti che invece “fanno” la nota non temperata, come gli archi, che distinguono tra diesis e bemolle. Secondo lui, faceva parte del margine di adattamenti richiesto dal nostro orecchio anche se a noi non sempre risulta. Provava un grande rispetto e una grande ammirazione per la complessità tecnica della musica moderna, in armonia, timbri, ritmica, tavolozza strumentale e provava un vivo piacere nel possederla; per lui era già quello un contenuto espressivo, l’esistenza di un mondo, il mondo sonoro che aveva gradatamente sostituito le intenzioni mistiche della musica orientale. “Loro non hanno progredito come tecnica”. Poi, poteva scherzare sulla bravura crescente dei compositori nell’esser descrittivi, e in particolare nel descrivere temporali, tempeste e bufere, da Vivaldi a Beethoven, e via via fino a Richard Strauss: “Quello, nella Alpensymphonie non lo batte nessuno. ..” . E gli occhi azzurri ridevano divertiti, come in altro momento a raccontare la burla dell’organo e la sua “sghignazzata”. Quegli occhi potevano diventare luminosi e lieti, o duri e metallici, secondo la luce e secondo l’umore. Quegli occhi che volle venissero donati quando fosse morto; e che oggi vivono e vedono in una vita più giovane e probabilmente ignara.
Ogni tanto si rammaricava di non poter tornare a dirigere: “Potrei anche farlo, per una volta; ma non sarebbe giusto; quando mi sono ammalato, avevo tanti impegni; mantenendone uno, dovrei mantenerli tutti. E poi… c’è anche l’artrite. Per una professione atletica come la mia, è veramente il colmo…”.
Non doveva aver molta fiducia nel suo prossimo. Se no, perché cominciare una lettera: “Alcuni amici — fidati amici —mi hanno fatto leggere il Suo articolo…”. Credo che in quello auspicassi che potesse almeno una volta ritornare sul podio. Vi era ritornato, sì, una volta sola, per dirigere la “marcia funebre” dell’Eroica ai funerali di Arturo Toscanini.
“Toscanini è stato il mago che ha illuminato la mia giovinezza”. Forse, dal giorno in cui Toscanini lo aveva diretto, allievo addetto ai timpani nell’orchestra degli allievi del conservatorio, aveva visto in lui un demiurgo hoffmanniano. Poi un temperamento diverso lo aveva allontanato, senza tuttavia che il grande esempio si affievolisse.’ 2 Neppure per l’assurda contesa, nell’orchestra della Scala, tra orchestrali più o meno emiliani e più o meno veneti, gli uni scioccamente toscaniniani, gli altri non meno scioccamente desabatiani. Neppure per schieramenti che si nascondevano (ma non troppo) in ambienti milanesi degli anni Cinquanta. Basta osservare le fotografie dove i due maestri conversano insieme, nella platea semibuia della Scala, durante una prova, l’atteggiamento di de Sabata, sporto in ascolto verso Toscanini.
Tutti e due da pochi mesi avevano smesso di dirigere. Forse non se ne ricordavano. Proprio in quella stagione, la Scala, ottimista per giusta fierezza, li aveva messi in cartellone tutti e due. Non era mai avvenuto. E purtroppo, quei nomi eran rimasti sulla carta.
1 Teodoro Celli. L’arte di Victor de Sabata. ERI, Torino 1978
2 Cfr. In Guido M. Gatti, Victor de Sabata, Kistner, Genève; Ricordi, Milano 1958
