TESTIMONIANZE
TESTIMONIANZEPer Victor de Sabatadi Gianandrea GavazzeniTratto da: “Victor de Sabata – Nel centenario dalla nascita”, Teatro alla Scala, 1992.
Testo letto nel Ridotto del Teatro all Scala di Milano il 17 dicembre 1977, a dieci anni dalla morte del Maestro.
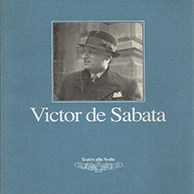
È proprio per lui, per Victor de Sabata, che possiamo dire: una vita intera calata nella vita della musica. Tra quante esistenze di musicisti il nostro tempo ha conosciuto — compositori, interpreti — è stata la sua tra le più totali e assolute. E di una forma così originale da non somigliare ad alcun’altra.
Una forma che realizzava l’identità dei caratteri artistici e degli umani. Chi ebbe comunanza di lavoro o di amicizia può ben ricordare la verità di questa immedesimazione. Ecco: il rapido scatto di un giudizio, sui fatti della musica e sui fatti della vita, sulle vicende della cultura, il tratto anche vivacemente pittoresco nel punteggiare un ambiente o un evento. Le sue sintesi balenanti; la definizione geniale, secca; o il secondo spazio che stava oltre un’idea critica. Cioè lo spazio della poesia, lo spazio dei sentimenti.
E infine c’era il suo disegno fisico a suggellare l’unità. Un disegno tipico; da non poterne immaginare altro diverso quando la realtà spirituale e la interpretativa assumevano espressione. E anche quando, prima o dopo la musica, interveniva il comportamento pratico.
Non va dimenticato: de Sabata nasceva a Trieste (il 10 aprile 1892). Il suo temperamento, l’inquietudine del carattere, rivelarono sempre qualcosa dell’origine nativa. Chi ha carpito il mordente triestino lo sa: i modi del vivere, i crinali di culture diverse, a Trieste. Sul versante dei tratti fisici una somiglianza desabatiana è forse nel ritratto di Umberto Saba dipinto dal triestino Bolaffio, su un fondale di luce adriatica.
Conosceremo poi, negli anni di piena maturità, la trafittura dello sguardo, azzurra o d’acciaio, dove appunto di quell’origine balenava ancora il riflesso. E nei contatti con lui, i segni tipici di quella forma umana che sarà tutta assimilata nella forma artistica. Ecco: il linguaggio mimico delle mani, articolato senza soluzione nel passare dall’espressione della parola all’attuazione della musica. La voce: che poteva suonar dolce e suasiva; e accendersi, secca e tagliente, nel soprassalto irato. Oppure assottigliarsi di timbro nel dar parole, in un colloquio amichevole, agli incantesimi di una partitura. L’arcata delle lunghe braccia, che diventerà elemento dell’operazione direttoriale, dell’arcata stessa interpretativa. Spiccava, su tutto il rilievo sculturale del viso, il pallore tenace. E in un’ora funebre di Santa Margherita Ligure — il 10 dicembre 1967 — parvero unire senza frattura l’identità della vita con l’identità della morte. Dalla realtà vivente alla pausa del Mistero, il viso, le mani, il pallore di de Sabata non ebbero mutamento.
Avendo raccolto, durante tanti anni, la suggestione e il fascino di un uomo musicale, il nome stesso, pronunciandolo, udendolo pronunciare, leggendolo, ci risultava indissolubile da chi lo portava: non ne avremmo supposto altro diverso. Come se un’aura carismatica fosse annidata in quel nome.
Lo si ricorda oggi, qui, nel teatro dove egli svolse l’opera più continuativa, dando impronta di sé a tutto un periodo. Qui, dove un ‘suo’ pubblico gli rimase per anni fedele con entusiasmi che toccavano punte altissime. Quanti tra i suoi ammiratori sopravvivano ancora oggi possono ben ricordare l’accensione plaudente che scattava, prima dell’inizio esecutivo, al solo suo apparire nel varco della porticina dell’orchestra. Dalla platea, ai palchi, alle gallerie. Ogni volta. Era il saluto del ‘suo’ pubblico. La riconoscenza per quanto prodigava di sé; l’affetto, e il potere soggiogante di una individualità tanto diversa da ogni altra.
Ma proprio per tentare oggi un disegno delle caratteristiche e dei valori, è necessario nei tratti principali riandare alla biografia. Nella prima età, il passaggio da Trieste al Conservatorio milanese. Gli studi, sotto la guida di Michele Saladino e di Giacomo Orefice, conclusi nel 1910. Durante il tempo scolastico, a undici anni, la direzione di un concerto con gli allievi, che suscita stupore. La Suite orchestrale composta per il saggio finale, eseguita subito dopo alla Scala e in altre sedi sinfoniche.
Siamo in parecchi ad aver udito, da suoi compagni di studi, lo stupore causato da certi episodi durante il periodo scolastico. — Perfino da certi vecchi ‘bidelli’ udimmo qualcosa: il leggendario Francesco… — Episodi inerenti alla memoria sbalorditiva, alla prontezza tecnica, al pianismo, alla ‘lettura’ di partiture viste per la prima volta. La vocazione era triplice: pianistica, compositiva, direttoriale. Difficile la coesistenza. Ogni giovane inquieto, sotto il porticato “lombardesco’ del Conservatorio, accanto alla controriformistica chiesa della Passione, si sarà forse sentito personaggio in cerca di una rivelazione sicura, di una strada. Forse già allora, per il giovane Victor, il dualismo tra il compositore e l’interprete era in atto. E forse la volontà direttoriale andava liberandosi proprio in virtù di certe fulminazioni tecniche, attraverso gli sguardi trafiggenti gettati nelle musiche altrui.
Prevalse, in un primo tempo, il compositore. E con rilevante interesse; se vediamo che nel 1912 Tullio Serafin dirige qui alla Scala l’idillio orchestrale” Tra fronda e fronda; che nel 1917, sempre alla Scala si rappresenta l’opera Il macigno. E infine Arturo Toscanini include il poema sinfonico Juventus nella tournée americana e italiana del 1920 con l’orchestra che sarà poi quella dell’Ente autonomo scaligero; ripetendolo ancora nella tournée europea del ’24. E sempre Toscanini presenta in prima esecuzione Gethsemani nel 1925. Io stesso, negli anni di studio romani, ascoltai la prima esecuzione dell’altro poema, La notte di Platon, diretta dall’autore.
Certo, de Sabata compositore è figlio del suo tempo; e di un tempo ‘milanese’ particolare. Di pochi anni prima la diffusione di Strauss, Debussy, Ravel, del primo Stravinskij: la scoperta dei Russi. Una Milano musicale che si sottraeva al boitiano governo dei giudizi — «s’el dis el Boito», la domanda rituale dei vecchi musicofili ambrosiani andava tacendosi. Nel tecnicismo desabatiano c’era la sintesi di quella cultura, il risultato di quelle scoperte. E al centro l’interesse per l’orchestra. L’orchestra come scopo e come poliedro di un organismo musicale; cioè l’orchestra quale idea centrale circa il far musica in una società, e circa il fare della musica una ragione totale di vita. Ed è forse qui, nella puntualizzazione orchestrale del de Sabata compositore, la radice di quanto prevarrà in seguito nella vita del musicista-direttore: l’orchestra come partizione analitica, come scienza acustica; infine l’orchestra delirio, raptus, incantesimo e magia.
Quando in una storia come quella di de Sabata hanno convissuto fino a un certo punto due pratiche, la inventiva e la interpretativa, ci si chiede quale la ragione vera perché l’una venga abbandonata per esclusivo impegno sull’altra. Motivi realistici di vita, di tempo; occasioni, circostanze di fortuna. Ma insieme, e certo con maggiore intervento, è il calarsi totalmente nei testi altrui, in altri mondi poetici cristallizzati storicamente, ad alimentare l’insoddisfazione per l’opera propria. È infine un processo di appropriazione che viene compiuto sulle musiche studiate ed eseguite. Non l’interprete come creatore, o ricreatore, ma l’interprete come ‘proprietario’. Troppo impetuosa, dunque, nel Maestro, l’insorgenza della natura musicale perché egli trovasse appagamento negli elaborati sottili delle sue partiture, nelle assimilazioni culturali e di gusto indicate prima. La sua idea e pratica di musica come fenomeno totale di vita chiedevano altro. Era una fame di musica, fisica e spirituale, da gettare nei fuochi dell’assoluto. Ideale ancora romantico? Sì: ove, oltre alla nozione di Romanticismo storico, intendiamo tutte le espressioni successive, sino alle soglie dell’Espressionismo europeo. L’artista come demiurgo, eroe, dominatore dell’opera altrui; da rivelare mediante acustiche nuove, da carpire in quei segreti inventivi dei quali in certi casi nemmeno gli autori stessi avrebbero immaginato il valore o la risonanza. In de Sabata non c’era atto di superbia, di fronte ai grandi testi della musica, da Beethoven fino a Debussy e oltre. Era atto di amore e di cultura. Era, attraverso le partiture, un porsi davanti agli uomini che le avevano create e chiedere con tutta la capacità tecnica e l’assillo morale: «chi eri? cosa sei stato? perché hai scritto questo?».
Inoltre, portando i suoi ascoltatori a risonanze e misure nuove, esaltando le partiture ‘storiche’ al limite della tensione, era come indicare che il punto di rottura si avvicinava, che nella nozione di ‘musica’, tra l’Umanesimo e l’Espressionismo, non era possibile andare oltre. Bruciava un mondo, intorno, e non soltanto nella musica. De Sabata, in campo interpretativo, ne fu un bagliore estremo. Sarebbero sopraggiunti altri eventi. Ma non più su quella strada.
Primeggia dunque il direttore sul compositore, ho già accennato. Con una svolta che diventa presto definitiva. La direzione stabile al Teatro di Monte Carlo, dal 1918 al 1929. Una vasta esperienza nel repertorio francese, italiano, tedesco. Punto centrale la prima esecuzione dell’Enfant et les sortilèges. di Maurice Ravel. E’ noto: Ravel ne fu entusiasta. Dal ’30 l’entrata alla Scala, per non più abbandonarla, salvo brevi interruzioni, e negli anni tra il ’43 e il ’47; fino al malore che spezzò la sua ‘bacchetta’. Un trentennio siglato dalla presenza protagonistica. Aperto l’8 febbraio 1930 con La fanciulla del West di Puccini. Segnò l’attacco orchestrale, allora, una lama di sonorità mai dimenticata da chi fu presente.
È problematico analizzare l’arte di un direttore d’orchestra; approssimativo ridarne qualcosa mediante le parole. Fa da ostacolo la rapidità dell’impressione. Ciò che muta, da un attimo all’altro, nell’atto esecutivo. È arte veloce l’esecuzione musicale. I momenti di ascolto non concedono tregua. Scatta appena un’impressione e già sta accadendo altro. Formuli un pensiero, ed è già tardi; incalzano eventi nuovi. L’oggettivazione di un giudizio è continuamente messa in forse dalla fluidità della materia, dallo scoccare di altro momento. Per tentare qualche cenno sull’arte desabatiana da indicare a chi non fece in tempo a conoscerla, da rievocare a chi l’ebbe familiare, occorre dunque affidarsi al ricordo. Occorre recuperare le sconvolgenti emozioni legate alle sere vissute in questo teatro.
Anche l’ascoltatore non professionale percepiva che balzavano in luce nuove aperture nei modi di governare un’orchestra e di leggere gli autori. Perfino gli obiettori o i detrattori (e ce n’erano pure) reagivano proprio per quanto vi era di insueto nella visione del Maestro e nelle sue attitudini visive. Mentre i musicisti, gli addetti ai lavori, localizzavano questo rivolgimento della funzione direttoriale nella nuova gestualità legata ai caratteri personali di fondo. Linguaggio del gesto come linguaggio della musica assunto a una trasfigurazione individuale. Appunto un atto di possesso — come accennato prima — che appariva ai tradizionalisti talvolta sopraffattorio. Ma qui si entrava — come è stato per ogni vero `interprete’ — nella perenne discussione sullo spazio interpretativo, sul perenne movimento dei testi musicali. La rottura di certi schemi era il mezzo diretto per carpire alla partitura la carica e il divenire di certi contenuti. Era la complessiva fisionomia artistica e psicologica a non poter seguire itinerari ripetitivi, pur desunti da modelli illustri. Da qui l’acuminato prevalere di certi timbri, nel contesto strumentale, la delineazione di sortite tematiche secondo il fantasma poetico che De Sabata strappava alla rigida struttura ritmica. Da qui, ancora, il mutamento di segni dinamici originali. Entrando dunque di netto in un problema chiave circa il quando, il come, il perché, i ‘coloriti’ d’autore possano o debbano venir alterati. Base di tutta questa operazione era in lui il virtuosismo concertativo, la conoscenza capillare degli strumenti, l’orecchio dalle sottigliezze acustiche quasi ossessive.
Ne sapevano qualcosa i suoi collaboratori orchestrali. E potrebbero darci testimonianze precise. Ma taluni scomparsi; altri troppo presto pensionati… Io stesso ricordo, durante le prove dell’Enfant et les sortilèges di Ravel nel 1948, la sua ‘insistenza sui suoni ‘armonici’ dei violoncelli, sulle diteggiature e le ‘posizioni’, senza che nessuno potesse obiettargli nulla, in sede di tecnica strumentale. E Bruno Ferrari, ancora oggi operante, ricorda il particolare di quella sortita del trombone, sempre nell’Enfant raveliano, che de Sabata voleva in ‘quarta posizione’, per la chiarità del colore. Obliandolo all’esecuzione, il Ferrari si vedeva, immancabilmente, quattro dita della mano sinistra ricordargli ciò che aveva dimenticato…
Ma ricordo pure che nello spettacolo raveliano del 1948 toccò a me dirigere Daphnis et Chloé e La valse. C’era da tremare: dirigere partiture dello stesso autore dopo di lui, spalla a spalla. Eppure il suo incoraggiamento e il suo consiglio furono tanto affettuosi da togliermi ogni soggezione. Così era anche l’uomo che in certi momenti poteva raggelare o far crollare chi collaborava con lui.
Sui presupposti del virtuosismo, della timbricità, delle nuove angolazioni, si parlò allora di un `sinfonismo’ operistico. Quasi a porre in ombra il fatto vocale. Ma era, pur con qualche eccesso, la concertazione unitaria sopra la propria idea di un’opera, sopra l’esistenza non soltanto edonisticamente vocale di quest’opera; ma esistenza segreta, sottesa, al di là dell’apparenza eloquente. E questa seconda esistenza, egli la voleva strappare ai limiti della convenzione, come un metallo prezioso viene strappato dalla pietra che lo rinserra. Vennero così le maggiori coincidenze tra il proprio personaggio e le opere. Cioè il pieno appagamento tra l’autonomia dell’interprete e l’autonomia dei testi.
Il Tristano e Isolda, dal quale si usciva in stato di ipnosi e di lucidità insieme. Per la consapevolezza di aver percepito tutto del poema drammatico; tutto del tessuto sonoro e della sua ‘poetica’.
Pelléas et Mélisande, che fu altro punto di convergenza totale. Uno specchio, l’opera, onde cogliervi riflesso il ritratto in piedi dell’interprete. E poi Sansone e Dalila, Ifigenia in Tauride, Salome. Dovunque una partitura, a seconda della sua collocazione storica, recasse determinati segni di una ricerca, il lampo di una combustione, ecco, la fantasia desabatiana decollava.
Opere legate ad affetti giovanili ne traevano tono vitale: L’amore dei tre re di Italo Montemezzi. Oppure la Fedora, i cui esiti timbrico-drammatici ricavati da de Sabata facevano trasalire con attonimento Giordano stesso.
E memorabili furono Butterfly e il terzo e quarto atto di Bohème. La Barriera d’Enfer punteggiata dal nevischio come in una tela di Claude Monet. Quando poi qualcuno della critica, per il fortissimo conclusivo del quarto atto, per quelle armonie delle trombe ch’egli portava a tensione lacerante, osservò che non moriva Sigfrido ma soltanto la fioraia Mimì, commentava sorridendo che in quel momento per Rodolfo è il mondo intero che crolla. Come nel caso della Canzone del salce nell’Otello.
Quando gli fu riferito che era ritenuta troppo lenta da qualcuno, specie nel ‘ritornello’ orchestrale tra una strofa e l’altra, poiché sempre di canzone doveva essere l’andamento: «… canzone, si — rispondeva — ma quale canzone, e in quale momento del dramma e della vita di Desdemona, e quale la tinta ambientale?».
Antonio Ghiringhelli e Luigi Oldani che gli furono vicini per tanti anni ricordano questi episodi. Ed altri che l’amico Ghiringhelli potrebbe rivelare in quel libro di memorie scaligere che dovrà pur decidersi a scrivere.
Incontriamo Verdi, nel lavoro di de Sabata. Il trovatore e La forza del destino, col seguito di discussioni, dubbi, critiche anche dure. Correva una fase di crisi nel suo rapporto con il Verdi del periodo centrale. Mentre colse in pieno il Verdi nuovo e problematico del Macbeth, portandone a gran fuoco la tortuosità psicologica, il buio d’anime, la magia vorticosa. Fu da lui che l’opera pervenne alla sua fortuna moderna. E mai più dimenticati, per chi ascoltò l’Otello e la Messa di Requiem. Qui, il rapporto tra congenialità e oggettivazione toccò la perfezione.
Del tutto conseguente, in un Maestro che tanto esaltava i valori orchestrali delle partiture operistiche, lo spazio occupato dall’attività sinfonica. Oltre agli innumerevoli concerti scaligeri, ai Maggi Fiorentini, a Santa Cecilia. Ogni volta, immancabilmente, l’esito toccava punte trionfali. -Esiste perfino il rapporto di un commissario di polizia romano, del 1935, sui tumulti accaduti al botteghino di Santa Cecilia per l’acquisto dei biglietti: risse, vetri infranti, accorrere di poliziotti…
E con esiti uguali le molte sortite in Germania, Inghilterra, Stati Uniti.
Se tentiamo a distanza una nozione centrale del suo sinfonismo, ecco: come nell’opera teatrale l’ago di bussola tendeva all’orchestra, il suo sinfonismo puntava al dramma, all’evidenza rappresentativa, alla pittura. Tendeva insomma a far diventare personaggi di un evento i materiali di una ‘sinfonia’. Da qui il ‘suo’ Beethoven e il ‘suo’ Brahms, che furono discussi, ma che muovevano turbamenti e problemi. Insegnavano a non impigrirsi sulle nozioni acquisite.
Infine gli incantesimi fonici in Strauss, Debussy, Ravel. I suoi amori della giovinezza; di sempre.
Scarsa la discografia. E se ne possono intuire le ragioni. Chi, come lui, affidava il risultato dello studio, della meditazione, anche alla fantasia istantanea, alla mutevolezza, al raptus ispirativo, necessitava del contatto umano diretto con quello che si usa oggi chiamare l’utente. Necessitava del clima di un ambiente, della felicità immediata. Non poteva trovare appagamento nel gelido anonimato dei microfoni. Eppure rimangono due esemplari che fanno rimpiangere quanto d’altro avrebbe potuto accompagnarsi: Jeux di Debussy, con l’orchestra romana di Santa Cecilia; la Tosca, registrata alla Scala.
Il nuovo Debussy di Jeux che si affaccia sul futuro, portato a una condensazione oltre l’Impressionismo; dramma di oggetti sonori. La Tosca di questo disco: incantatrice e scarnificata; carica di Barocco romano e insieme sedimentata liricamente. Nervosa e crudelmente timbrica. Con un’alba, al terzo atto, che non si era ancora udita tanto profonda di echi. Ne sa qualcosa il collaboratore del Maestro, Antonio Tonini, sulle tormentate ricerche per le diverse distanze delle campane.
Infine il malore, costringendo al ritiro. E saranno gli anni di più chiuso segreto. Mai una recriminazione, una confidenza. Così era l’uomo, con i suoi enigmi, il suo riserbo, l’orgoglio di sé e il pudore; il rispetto verso gli altri.
Due anni di sovrintendenza artistica alla Scala. Quali le sue reazioni intime, ascoltando altri direttori nella concertazione? Costretto alla non partecipazione diretta, lui dominatore?
Eppure, avendolo alle spalle alle prove, nessuna inibizione, nessun disagio. Soltanto il consiglio amorevole, la comprensione, l’incitamento. Quanto gli sarà costato?
Poi l’esilio a Santa Margherita. Il segreto della sua solitudine. Diceva di aver ripreso a comporre. Ma sarà stato vero?
C’era in lui anche un’arte sottile di intrappolare chi voleva insinuarsi nella sua vita nascosta.
Una sola intermittenza: la morte di Toscanini. E fu il tributo al Maestro della giovinezza, al Maestro di sempre, al di là delle cabale imbastite dagli sconsiderati. Un ritorno fulmineo dall’esilio per dirigere la Marcia funebre dell’Eroica; una partenza immediata, dopo, appena deposta la ‘bacchetta’ che non avrebbe più rialzato.
Il rituale funebre che Milano sapeva concertare per i suoi grandi morti: Verdi, Puccini (— ed io ero in Duomo tra gli scolari del Conservatorio… —), Giordano. Tutta la città nelle strade e nelle piazze qui intorno.
Per Toscanini, i1 feretro nell’atrio, la folla fuori. La Scala vuota, e de Sabata, solo con l’orchestra a segnare per l’ultima volta nello spazio il canto beethoveniano alla Morte.
Toccò per lui, per de Sabata, dopo. Ero direttore artistico in questa sede. Decidemmo che l’orchestra scaligera eseguisse senza direttore ciò che de Sabata aveva diretto per Toscanini. C’era un incontro, nel procedere dei due grandi morti verso il Mistero, che non andava rotto da nessun’altra intrusione.
Custodisco due ‘bacchette’. Sono legate a due epoche per le quali la Scala è stata gloriosa nella storia dell’esecuzione musicale e nel mondo. La ‘bacchetta’ di Toscanini, donatami dalle figlie Wally e Wanda. La ‘bacchetta’ di de Sabata, dono dei figli Elio ed Eliana.
Sono certo che nessun direttore d’orchestra cosciente dei propri limiti, ardirebbe mai impugnarle.
San Francisco, California, novembre 1977
(Da La bacchetta spezzata, Nistri-Lischi. Pisa 1987)
