TESTIMONIANZE
TESTIMONIANZEProgetto d’Artistaun ricordo di Vincenzo Vitale (1908-1984)Tratto da: “Victor de Sabata – Nel centenario dalla nascita”, Teatro alla Scala, 1992
Ringraziamo il Teatro alla Scala per l’autorizzazione a riprodurre questo testo.
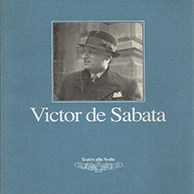
Claude Debussy, disegnando la partitura di Jeux, creò un’opera la cui esecuzione non potrà mai affidarsi al mestiere, anche se scaltrito, del comune sbacchettatore. Uscire da quel labirinto sottile e filigranato, non lasciarsi abbagliare e stordire dai guizzi coloristici del contesto strumentale, padroneggiarne il rapido fluire che ristagna o zampilla a brevi tratti, non è certo impresa che chiunque possa affrontare con speranza di successo. Molti, infatti, si tennero, e si tengono, prudentemente lontani dai pericoli di Jeux. Una cosiffatta ragnatela d’oro, trapunta di pietruzze lucenti, solo un ago fatato può distaccare dalla pagina e ricreare in suoni.
Alcuni tentarono: Victor de Sabata vi riuscì. Il groviglio delle combinazioni ritmiche e timbriche si dipanava all’insinuarsi della sua bacchetta fra i nodi del capzioso tessuto orchestrale. E tutto scaturiva limpido, trasparente. Le liquescenze sonore, che in altre mani avrebbero rischiato di agglutinarsi pesantemente o di svaporarsi in residui di note soffiate, risultavano al giusto peso: si combinavano nei loro contorni più luminosi e precisi.
Della triade Toscanini, Guarnieri, de Sabata, quest’ultimo fu il più quintessenziato prodotto d’un mondo di raffinata cultura. Questo distinto signore, alto ed elegantemente vestito, i cui occhi cerulei animavano un volto pallido e ben disegnato, parlava poco durante le prove e non insultava mai nessuno. Negli anni in cui era segno di personalità, per il direttore d’orchestra, evocare i defunti degli esecutori, e aggiungere pittoreschi e sessuali epiteti ai nomi venerati della Vergine e dei Santi, egli seppe contenere il suo eloquio nei termini della buona educazione. Dettaglio non trascurabile ove si pensi che, all’epoca, non v’era un sindacato pronto a proclamare, in caso di turpiloquio direttoriale, scioperi e conseguenti richieste di esilio del reprobo.
Quando Victor de Sabata s’avviava sul podio, claudicante ma eretto nella persona, appariva già immerso nel mondo sonoro che stava per suscitare con la sua autorità, con il suo prestigio d’artista. Ed il mistero della suggestione, che promana da chi sta un metro al di sopra della massa, era in lui più fascinoso che in altri più dotati di una comunicativa soggiogante.
Il suo gestire con la bacchetta era nobile e quasi distaccato, fatto di cenni appena intuibili, ma sapeva diventare violento e pesante quando fosse risultato necessario alla scansione d’un ritmo possente, che sottolineasse il titanismo d’un particolare dell’edificio musicale. La possibilità di adeguarsi ai vari momenti espressivi era, infatti, in de Sabata, d’illimitata ricchezza. Il passaggio dal Debussy di Jeux allo Strauss di Morte e trasfigurazione, dal Ravel di Ma mère l’oye al Rossini della Gazza ladra, avveniva senza che la sua sensibilità d’interprete fosse sollecitata a compiere acrobazie.
Ho detto Morte e trasfigurazione. Ecco. Nel ricordo riappare il gesto drammatico di Victor de Sabata. L’orchestra s’anima sotto l’urgere tempestoso dell’onda di musica. Il morente lotta con disperazione: la vita gli sfugge, inafferrabile. Poi l’agonia ha termine. Egli soccombe. Ma una luce improvvisa lo investe. Una palingenesi poetica lo ha reso trasfigurato, quasi impalpabile. Alla truculenza succede la contemplazione.
Bisognava avere non solo ascoltato ma visto de Sabata sulla pedana durante questo purificarsi della musica: quando all’umano sopravviene il transumano. Il gesto nervoso era, allora, annullato. Le braccia perdevano la loro quasi meccanica funzione di leve preposte a segnare il ritmo. Ricadevano senza più scatto. Solo il volto esprimeva un’estasi che l’agiografia ci ha tante volte descritto. Ma là dove la raffinatezza di percezione si rivela, in de Sabata, nel suo momento più alto, è in una pagina di Gioacchino Rossini, strapazzata ma pur sempre vittoriosa dei maltrattamenti: la Sinfonia della Gazza ladra. Ogni professionista del podio trova qui giuoco facile e tranquillità di risultati. Vadano comunque, le cose camminano spedite. Nessun intrico strumentale; periodare chiaro, temi di una vis espressiva senza risparmio. Ma è proprio qui, in questo regno beato della chiarezza, che la carica emotiva può straripare o limitarsi a dare il puro necessario. E, tra l’uno e l’altro estremo, è difficile raggiungere quell’equilibrio che accosta l’interprete al creatore.
Ed ecco de Sabata concertare la famosa Sinfonia. Le crome ribattute discendono per gradi, dal Si acuto all’ottava inferiore, seguite da una quartina ascendente di semicrome. Figurazione elementare, almeno in apparenza, e che non presenta particolari problemi di lettura al direttore affrettato, ma che de Sabata individua come momento supremo dell’ethos di Rossini: ne esplora le difficoltà di esecuzione, trova i mezzi idonei a superarle e li trasmette all’orchestra con efficacia di risultati. E poi: qui l’accento è troppo marcato, là il respiro è troppo lungo, ora il suono è troppo secco, ora troppo corposo; e così via. Tutto sempre più analizzato, ma, alla resa dei conti, ridotto a una sintesi di rara capacità espressiva. La cifra del grande concertatore.
Un concertatore così sensibile ed esigente anche dai concerti altrui che il violinista Guido Ferrari racconta di lui questo episodio. Una sera de Sabata sedeva nella prima fila di poltrone, alla Scala, durante l’esecuzione d’un’opera di Strauss. A un tratto, l’ottavino fa una “sortita”. Sbaglia. De Sabata, che assiste all’esecuzione come in trance, s’alza d’improvviso, e col fischio riproduce alla perfezione il passaggio.
Questo musicista nervoso e vibrante e, a un tempo, mite e contemplativo, non poteva sottrarsi alla suggestione del comporre. E scrisse alcune partiture. Ma il sospetto che il suo fosse un prodotto di mestiere gravò su di lui non meno che sui predecessori e coevi suoi. Non vogliamo qui citare il “caso” Mahler, ma solo quello d’altri personaggi pure degni d’attenzione: tutti vittime del più vistoso aspetto della loro professione: la direzione d’orchestra.
De Sabata, comunque, arricchì anch’egli, in compagnia di Alfano, di Pizzetti, di Respighi, di Ghedini (e non proseguo per ovvie ragioni d’opportunità), gli scaffali delle patrie biblioteche di alcune opere teatrali e sinfoniche: dico scaffali, giacché tutte le partiture di costoro sono completamente sparite dai leggii delle orchestre. Lui vivente, ebbe esecuzione non solo Il macigno, un’opera in tre atti, ribattezzata poi, per evitare banali commenti sul titolo, Driade. In essa, come nei poemi sinfonici Gethsemani, Juventus, La notte di Platon, onnipresente il pantheon dei musicisti da lui idoleggiati e di cui fu impareggiabile interprete: soprattutto Debussy e, più ancora, Strauss, come già avvenne ad un altro protagonista della bacchetta, Giuseppe Martucci, con Wagner e Brahms. Toscanini diresse spesso i tre poemi sinfonici. Strauss, che del loro autore era amico affettuoso, portò al successo Juventus al Colón di Buenos Aires. A questi famosi contemporanei di de Sabata si aggiungono oggi direttori di notorietà internazionale: Lorin Maazel, Eliahu Inbal, Aldo Ceccato, che eseguono spesso, soprattutto negli Stati Uniti, La notte di Platon. Notevole atto di fede in quella pagina da parte di musicisti ancora giovani.
(da “Il Giornale”, 11 dicembre 1977)
